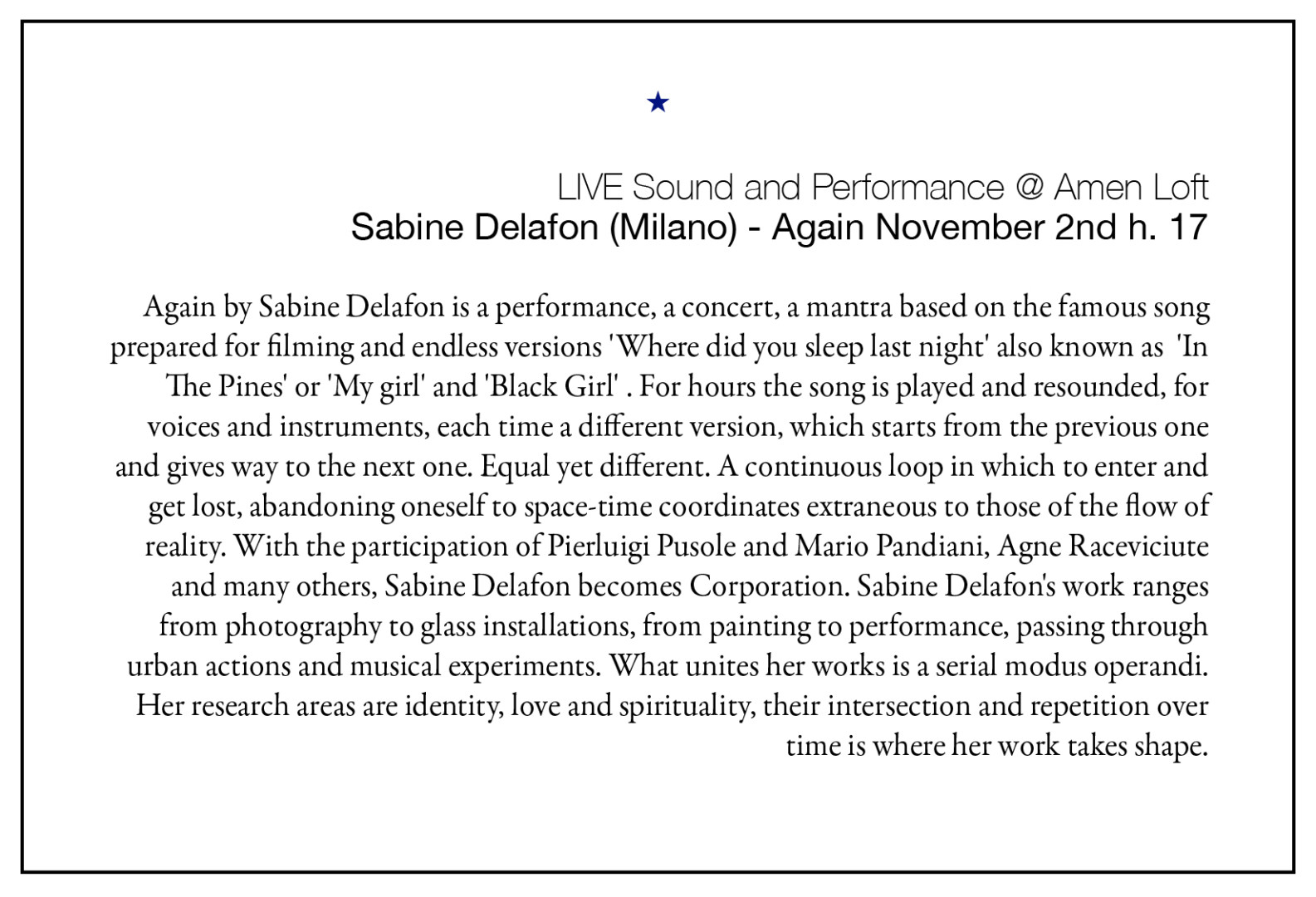I luoghi sono canzoni. Le canzoni sono luoghi.
Nei luoghi cammini, vedi, senti ‘la loro musica’, che è un mood dell’anima che ti risuona dentro, ti avvolge. E che riconosci, per affinità, anche altrove, dall’altra parte del mondo, può capitare.
Nelle canzoni trovi dei mondi, dei luoghi, fatti di immaginari, vibrazioni, volumi, angoli e slarghi, vie. Piccole città.
E spesso le une si fondono/confondono con le altre, diventano spazi mentali personali, per te che le incontri, e vanno oltre la loro dimensione reale. Perché ogni luogo, così come ogni canzone, è una serie di dimensioni una dentro l’altra, scatole cinesi che si aprono e contengono all’infinito. Spirali. Dentro le quali si può sprofondare, porta dopo porta, anello dopo anello, seguendo una strada che porta a sé stessi. Il percorso, infatti, lo si sceglietrovasegue ascoltandosi. Ognuno, in una canzone in un luogo, trova il proprio sentiero, disegna la propria spirale. Magari la scopre. E allora si fanno spazi dell’anima, un’appartenenza personale e intima.
Chissà perché certi luoghi, certe canzoni diventano frammenti proustiani della nostra vita. Richiami emotivi potenti che ci raccontano di altro, che evocano, che trattengono.
Again e again, ancora e ancora, un circolo via via ipnotico, pratica di attraversamento, di conoscenza, di perdita.
Sabine Delafone sceglie il luogo di una mitica canzone, Where did you sleep last night, che scorre lungo la storia della musica moderna in una metamorfosi continua, a partire dal titolo. Quattro quelli ufficiali: Where did you sleep last night, In The Pines, My girl, Black Girl.
Infinite, invece, le versioni (pare centosessanta tra varianti di testo e ri-arrangiamenti) di questa canzone folk americana, originatasi a sua volta da due canzoni, In the Pines e The Longest Train, ambedue di autori sconosciuti, risalenti alla seconda metà dell’Ottocento. È stata ripresa anche da Bill Monroe, Leadbelly, Nathan Abshire, The Four Pennies, Joan Baetz, Marianne Faithfull, Odetta, Bob Dylan, Grateful Dead, Nirvana, Marilyn Manson, LP.
All’interno dell’Emporium Sabine ne fa una performance, un concerto, un mantra, un’installazione sonora, un ambiente sonoro, una dimensione esperienziale. Al centro il meccanismo della ripetizione. Per ore la canzone viene suonata e risuonata, per voci e strumenti, ogni volta una versione altra, che parte da quella precedente e cede il passo a quella successiva. Uguale eppure diversa. Un loop continuo in cui entrare e perdersi, abbandonandosi a coordinate spazio-temporali estranee a quelle del flusso della realtà. Sabine crea uno spazio rituale, in cui la ripetizione si fa strumento lisergico. Voci, corpi, strumenti suonano e risuonano la stessa traccia. Un circolo.
La sua “Black girl in Shanghai” è figura fugace dall’apparizione virtuale, un’interferenza sensoriale a metà tra suono e immagine, che si decompone nel momento in cui sembra stia per definirsi. Si muove attraverso una visionaria città, un miraggio immateriale che sfonda lo spazio dell’Emporium aprendo una parete su un altrove. Un vapore che si condensa, partendo da uno scatto in bianco e nero per aderire come pelle al muro. La musica galleggia connettendo l’Emporium e questo luogo immaginifico -un’identità onirica che non è importante definire Shanghai-, che si dichiara condizione mentale ed emotiva più che reale. Un coagularsi di frammenti, di riflessi che si specchiano nella scultura in cui si articola l’installazione anche all’interno di Casa Casorati, dall’altra parte della strada. Una costruzione di vetri sovrapposti, un alambicco alchemico di bolle trasparenti che rimandano a immagini distorte, come uno schermo su cui visione, ricordo, percezione condividano lo stesso statuto. Vibrando delle rifrazioni sonore di una canzone infinita, dai titoli infiniti. Cerchi in uno stagno a disegnare spirali.
olga gambari